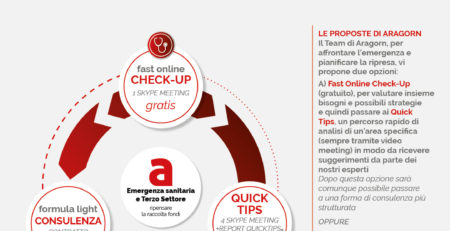Una nuova sfida per calcio e non profit: imparare a fare davvero squadra
Un tempo un noto allenatore scozzese disse che per lui il calcio – così come la vita – non era altro che un insieme di persone che lavorano unite per raggiungere un obiettivo comune (e alla fine ciascuna di esse porta a casa una parte del premio). L’allenatore in questione era Bill Shankly, la sua storia, mirabilmente narrata da David Peace in Red or Dead, ci restituisce una visione tanto rivoluzionaria quanto lontana, nella quale sovvertire il calcio e cambiare il mondo costituiscono in fondo un unico obiettivo, senza soluzione di continuità. E addirittura può accadere che il calcio diventi uno strumento per migliorare, almeno un po’, il mondo.
Della romantica visione di Bill Shankly oggi non sembra sopravvivere molto, anzi: la sensazione diffusa è che il calcio sia diventato uno sport e, perché no, un sistema svuotato di ogni etica, sentimento e senso di comunità, ormai irrimediabilmente corrotto da una disponibilità eccessiva di denaro, da scandali a ogni livello, dalla totale assenza di interesse per ciò che accade nel mondo.
Eppure proprio negli ultimi mesi qualcuno ha deciso di cercare di recuperare almeno in parte la visione di Shankly, di tornare a parlare di un obiettivo comune, di un #CommonGoal per la precisione, che parte dal calcio e attraverso di esso arriva fino al mondo reale.
Il #CommonGoal di Juan Mata & C.: cambiare il calcio e il mondo un 1% alla volta
A inizio agosto Juan Mata, centrocampista spagnolo del Manchester United, ha annunciato per primo di aver deciso di destinare in beneficenza l’1% del proprio stipendio, che si dice ammonti a £7m all’anno. Nella fattispecie le costanti donazioni di Mata confluiranno nel fondo comune Common Goal, promosso dalla ong streetfootballworld per finanziare tutti quei progetti internazionali che trovano nel calcio il proprio strumento di sensibilizzazione e cambiamento (dall’uguaglianza di genere in India ai processi di consolidamento della pace in Colombia fino all’integrazione dei rifugiati in Germania).
Un fondo comune come primo, immediato, obiettivo, quindi. E proprio perché il calcio è uno sport di squadra, in cui si vince e si perde tutti insieme, occorre agire e contribuire tutti insieme anche sul fronte sociale. Ecco così che il secondo step dell’iniziativa promossa da Mata presuppone una sensibilizzazione e un coinvolgimento dei colleghi, esortati a far parte di una sorta di formazione ufficiale del bene, una Common Goal Starting XI, caratterizzata da valori condivisi e dal fermo impegno a cambiare il mondo una donazione (o percentuale) alla volta. Il primo a rispondere alla convocazione è stato Mats Hummels, difensore tedesco del Bayern Monaco, seguito da due dei volti più celebri del calcio femminile, le statunitensi Megan Rapinoe e Alex Morgan, e, proprio nell’ultima settimana, da Serge Gnabry, ala tedesca in prestito all’Hoffenheim, e da Giorgio Chiellini, difensore della Juventus e della Nazionale Italiana, grazie al quale il progetto approda quindi anche in Italia e ci riguarda ancora più da vicino.
Sono molto felice di annunciarvi che ho deciso di aderire al progetto sociale #CommonGoal 🙂 @juanmata8 @matshummels @alexmorgan13 @mPinoe pic.twitter.com/5o47LOP8ua
— Giorgio Chiellini (@chiellini) September 29, 2017
In che cosa consiste poi il trofeo del bene, il #CommonGoal ultimo? Secondo quanto dichiarato dallo stesso Mata, nel riuscire a stabilire una connessione duratura tra il calcio come business e il calcio come strumento di cambiamento sociale, facendo in modo che l’1% degli introiti dell’intera industria – che, secondo una stima contenuta, si aggira intorno ai $30 miliardi all’anno – venga devoluto in beneficenza.
L’insegnamento di #CommonGoal: come calcio e non profit possono fare la differenza, insieme
Se ormai la maggior parte dei calciatori, e in generale l’intera industria calcistica, è perfettamente consapevole di avere una responsabilità e di poter fare la differenza non solo nel proprio ambito di interesse, sul campo, ma anche nel mondo reale, in termini di impatto sociale, la vera sfida diventa sempre di più capire come. Da questo punto di vista quindi l’esperienza di #CommonGoal può insegnare qualcosa tanto al mondo del calcio quanto a quello del non profit.
Da un lato, il primo è chiamato a spogliarsi della presunzione che lo status, l’immagine e il potere mediatico di calciatori e club possano bastare. In tal senso, accade spesso (non sempre) che una simile autoreferenzialità risulti problematica e addirittura controproducente, perché si traduce nella istituzione di onp personali, che si fondano più sul nome del calciatore che su criteri di trasparenza, sostenibilità e responsabilità, oppure nel sostegno a progetti di dubbia concretezza e affidabilità. La risposta, per l’industria calcistica, risiede invece in una attiva, consapevole, informata collaborazione con il settore non profit e in un dialogo costante con le onp già esistenti, cosicché, ad esempio, le Fondazioni istituite da calciatori e club possano arrivare a sostenere, amplificandoli e potenziandoli, progetti seri e strutturati avviati da onp con esperienza.
E, dall’altro lato, che cosa può invece imparare il settore non profit, che cosa possono fare le suddette onp per attirare l’attenzione (e con essa le donazioni) dell’industria calcistica? In questo caso la soluzione è puntare su un movente potentissimo, quello dell’interesse, della passione: largo quindi a progetti in cui il calcio, o in generale lo sport, sia il principale motore del cambiamento sociale; a quelli in cui il beneficiario sia la comunità che “ruota” intorno a un club o la città in cui viene organizzato un evento sportivo; a quelli infine che assecondano una passione extra-calcistica o una sensibilità personale dei diretti coinvolti. E al tempo stesso dare ai calciatori e ai club una possibilità, una scelta: quella di non dover più agire in modo isolato e circoscritto, bensì di partecipare ed essere coinvolti in qualcosa – una idea, una visione – di più grande.
Insomma, calcio e non profit possono fare la differenza insieme, possono trovare insieme il loro #CommonGoal: una via condivisa, sostenibile ed efficace per fare in modo che l’industria calcistica restituisca qualcosa alla società e abbia su di essa un impatto positivo a lungo termine, su scala globale. Perché, sì, in fondo tutti noi speriamo che il calcio abbia (ancora) il potere di cambiare il mondo, un po’ alla volta, che possa (ancora) essere qualcosa di più che un semplice sport e qualcosa di meglio che un mero business.
Fonti
bbc
fourfourtwoskysports
sport.sky
theguardian (1, 2, 3, 4)
theplayerstribune
ukfundraising
wikiquote